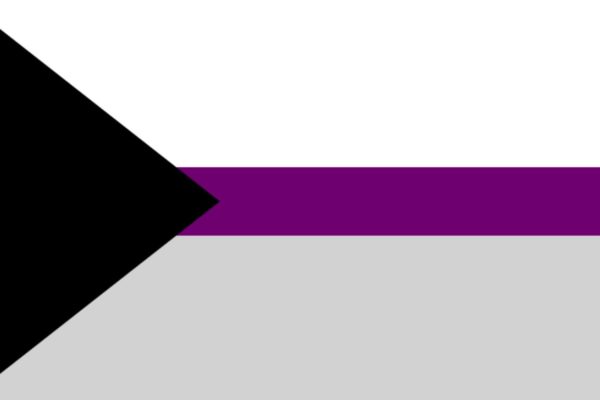L’interesse dell’opinione pubblica per il carcere, così come quello per tutto ciò che sentiamo distante da noi e che ci arroghiamo il privilegio di poter a nostro piacimento ignorare o considerare, risulta estremamente incostante. Spesso tale tematica viene innalzata agli onori della cronaca, come avvenuto qualche mese fa col caso Cospito, ma ben presto l’interesse scema e la bulimia di notizie dei giornalisti e dei lettori si dirige altrove. Eppure la vita dei detenuti continua, anche lontano dai riflettori, così come quella di coloro che in carcere lavorano, e con essa sopravvivono e proliferano i problemi al sistema penitenziario correlati. Proprio tra le tante cose che indebitamente ci sentiamo in diritto di ignorare, forse il carcere è la più insidiosa. La connessione tra realtà penitenziaria e mondo esterno, infatti, è tale che tutte le falle, le mancanze e le problematiche di questa si riversino violentemente sulla società “libera”, condizionandola molto più di quanto sembrerebbe. Come si è già molte volte detto, dunque, se non riusciamo a interessarci al carcere per altruismo e coinvolgimento umano, sarebbe opportuno farlo per egoismo e tutela del proprio interesse.
Rieducazione: un diritto non sempre garantito
Prima di intraprendere una qualsiasi trattazione meramente ideologica sul carcere, converrebbe partire dalla nostra carta costituzionale e in particolare dall’articolo 27, che stabilisce: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L’unica finalità della pena menzionata in Costituzione, dunque, risulta quella rieducativa. A questa, ed è evidente, se ne affiancano altre, in quanto, filosoficamente, la sola rieducazione non basterebbe a sostenere il concetto di pena, pur restando il fine ultimo della detenzione. Nonostante costituisca un diritto fondamentale e costituzionalmente riconosciuto, la funzione rieducativa viene frequentemente meno. Ciò a causa di molteplici e vari fattori, tra cui, primo fra tutti, il sovraffollamento, da intendersi non soltanto come mancanza di spazio fisico, ma anche come carenza di personale. Le maggiori problematiche si registrano soprattutto in relazione al personale non di custodia, a partire dai direttori penitenziari, spesso posti alla guida di più istituti. Sia sufficiente pensare che l’ultimo concorso prima di quello che si è recentemente tenuto e per il quale sono attualmente in fase di formazione 57 direttori risale agli anni Novanta. Non più florida è la situazione degli educatori, ai quali sono in media assegnati tra i 100 e i 200 detenuti: fattore che certamente confligge con la necessità di dedicare a ciascuno un’attenzione individuale al fine di garantire un percorso personalizzato, come prescritto dalla legge penitenziaria italiana.
L’utopia della reintegrazione sociale
Il problema del sovraffollamento va a discapito della reintegrazione sociale, che dovrebbe essere il principale obiettivo del carcere, ma che, allo stato attuale delle cose, salvo rare eccezioni, appare più un’utopia che altro, anche a causa del vastissimo divario con la società libera. “La vita in carcere è un mondo molto separato dalla vita normale, anche se non dovrebbe essere così. Il nostro modello di carcere dovrebbe essere immerso nella società e lo scambio tra carcere e società dovrebbe essere osmotico, attraverso i molti progetti di volontariato in carcere e la possibilità per i detenuti di lavorare all’esterno della struttura penitenziaria, tornandovi a dormire la sera. Questa opportunità è molto importante, anche perché costituisce un possibile sbocco lavorativo per il futuro. La vita interna al carcere dovrebbe essere il più simile possibile a quella della società libera, escludendo ovviamente la libertà di movimento”, ci spiega Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, associazione impegnata, dalla fine degli anni Ottanta, nella tutela dei diritti dei carcerati. “I maggiori problemi all’uscita – continua Marietti – sono dovuti alla discrasia tra il carcere e il mondo esterno e ai grandi problemi relazionali che riscontra un detenuto. Ciò porta con grande facilità a recidive, il cui tasso in Italia supera il 60%, collocandosi nettamente al di sopra della media europea”.
Abbandono a se stessi: unica costante della vita dei detenuti
Un altro importante problema del sistema penitenziario attuale risiede nella sostanziale assenza di supporto psicologico. Al momento dell’entrata in carcere, infatti, un detenuto viene sottoposto ad un check-up generale, comprensivo di colloquio con lo psicologo. A seguito di tale primo incontro, la terapia prosegue esclusivamente se lo specialista individua un rischio di suicidio, dunque se viene attivato il protocollo antisuicidiario. In tutti gli altri casi il detenuto è lasciato fondamentalmente a se stesso nello scontare la pena, spesso avendo come sola figura di riferimento il personale di guardia, il quale, tuttavia, non è formato per offrire alcun tipo di assistenza psicologica né educativa e viene spesso sovraccaricato di responsabilità che non gli spetterebbero. L’ordinamento penitenziario, in poche parole, si fonda sulla credenza, per certi versi folle, che la sola detenzione, scontata spesso in condizioni disumane e disumanizzanti, sia di per sé rieducativa. In quest’ottica, indagare sulle cause dell’alto tasso di recidiva dovrebbe risultare non complesso. Per risalire alla più grande criticità del carcere, tuttavia, secondo Susanna Marietti è necessario fare un passo indietro: “La più grande problematica del sistema penitenziario deriva dalla più grande problematica del sistema penale, la quale deriva a sua volta dalla più grande problematica del sistema sociale. Viviamo in una società che, avendo dismesso una serie di strumenti di welfare e avendo accantonato numerose iniziative educative e culturali e di politiche sanitarie, del lavoro, dell’outing sociale, relega ai margini quote sempre più grandi di persone, che, dimenticate e lasciate a loro stesse, vengono intercettate dal sistema penale, cadono nelle sue maglie e finiscono in carcere. Coloro che entrano in carcere in massima parte non hanno compiuto chissà quale reato, ma sono quegli stessi individui che non siamo stati in grado di gestire fuori con altri strumenti”.
La narrazione distorta e romanticizzata del carcere
Alle summenzionate problematiche se ne aggiunge un’altra, decisamente meno ingente ma non per questo inesistente, ossia la spesso distorta, a tratti romanticizzata, narrazione del carcere condotta all’esterno, quasi a volerlo trasformare in un idilliaco luogo dove “si sta meglio che fuori”, nonché a ridurlo a mero tessuto espressivo e tematico cui attingere per fortunati prodotti cinematografici o libri. Tale tendenza sfocia inesorabilmente in sentenze generalizzate di carattere assoluto e irrevocabile. Esiste tuttavia una condizione avversa per propria definizione alla comprensione di qualsiasi argomento. La conoscenza, infatti, richiede per sua natura capacità di mettersi e di mettere costantemente in discussione la realtà circostante, non negando l’esistenza di valori intangibili, ma al contempo essendo disposti a rivedere costantemente le proprie posizioni. Quel che è valido in ogni caso assume in particolar modo valore innanzi alla vicenda umana, infinitamente varia e frammentata. E ciò che è valido in relazione alla vicenda umana acquisisce a maggior ragione vigore per quanto riguarda il carcere, espressione massima della convivenza di persone delle più disparate condizioni. Ciò a dire che, per quanto infinitamente più semplici e comode, le generalizzazioni in questo campo sono da rifuggire in quanto nel migliore dei casi fuorvianti se non addirittura dannose.
A cura di Giulia Maglio e Alessia Prunecchi