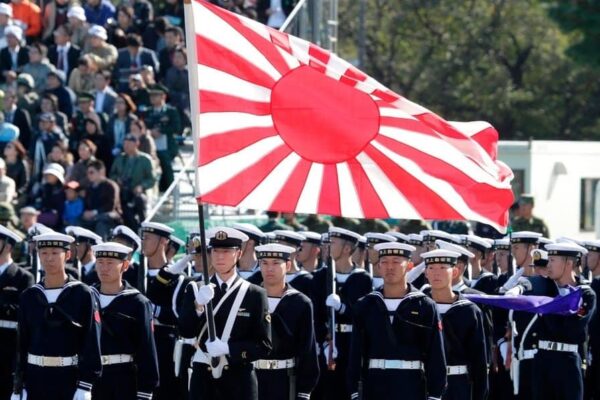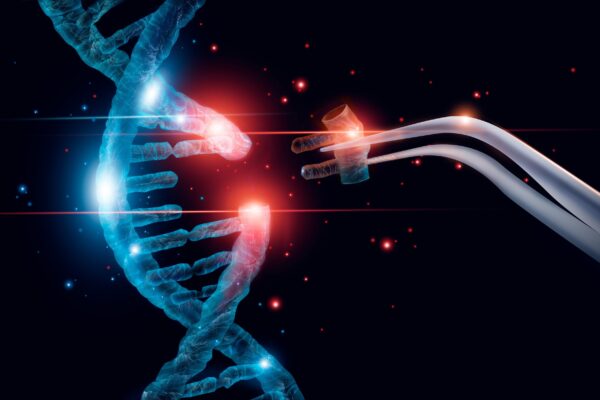Non è forse vero che le basi della nostra civiltà si fondano sullo studio del passato? E non è altrettanto vero che l’unico mezzo a nostra disposizione, oserei dire, “prestatoci dal tempo”, per comprendere noi stessi e gli altri sia la cultura? C’è forse qualcosa di più importante e magnifico per ogni popolo rispetto alla conoscenza delle proprie origini?
L’arte, la letteratura, la storia, il teatro e la musica sono le uniche vere forme di dialogo tra le nazioni. Quelle che permettono di vincere le disuguaglianze e di unire le civiltà in un comune destino: la vita stessa.
La cultura non fa discriminazioni, non crea conflitti o incomprensioni. Arricchisce e insegna a costruire il futuro, ad istaurare rapporti con tutti gli esseri viventi e ad imparare a conoscere se stessi.
L’arte è l’unica vera lingua comune a ogni popolo, la sola parlata in qualunque angolo della Terra; è la nostra finestra aperta sul passato, sulle nostre radici. Quella che ci permette di essere liberi e di sentirci come tali. Dovremmo fare, dunque, della cultura il nostro punto di forza, la nostra unica arma per vincere la guerra e per ristabilire la pace. L’unica strada da percorrere per raggiungere l’uguaglianza e la felicità.
La conoscenza è e dovrebbe essere un fattore di affratellamento e di accordo, non motivo di rivalità. È dunque impensabile prescindere dalla cultura in quanto simbolo di fusione e non di disgregazione e disunione. Spesso si sente dire che “noi siamo la storia”, ma aggiungerei, se mi è consentito, che noi siamo “solo” gli eredi della storia, i figli del tempo e che, essendo in possesso di un patrimonio talmente immenso, spetta a noi interpretare e comprendere tale processo affinché troneggino la collaborazione e la tolleranza nei confronti di tutti e soprattutto di noi stessi.
Ciò che sta accadendo in questi giorni non solo in Ucraina, dimostra quanto la cultura ed ogni forma d’arte, siano impiegate non come paladine di pace, bensì piuttosto come impedimento o motivo di tensione tra i Paesi.
Il fatto, ampiamente discusso da vari giornali, della censura avvenuta all’università Bicocca di Milano nei confronti di una lezione dedicata allo scrittore russo Dostoevskij che avrebbe dovuto tenere il professor Paolo Nori, è assolutamente indicativo del livello di un’interpretazione sbagliata attribuita alla cultura. Voler rimandare, infatti, la spiegazione su un autore di tale calibro e importanza, che ha combattuto per buona parte della vita, contro la sofferenza ed il pensiero della morte (per poco schivata), significa, infatti, cercare un nemico laddove avrebbe dovuto esserci un punto di incontro.
Per dirla con le parole di Nori: in questo periodo “si dovrebbe parlare di più di Dostoevskij”. Nessuno infatti più dell’autore di “Delitto e castigo” può essere tanto indicato, in questo momento di guerra ed orrore, come messaggero di pace. Sì, proprio lo scrittore moscovita che ha sempre condannato la tortura e la pena di morte, che ci ha fatto dono delle sue riflessioni sulla vita e sulla voglia di vivere a costo di starsene su uno scoglio a strapiombo sul mare senza neppure potersi muovere.
Dostoevskij parla della pena capitale, è vero. Ma non è forse quella atroce condanna senza ritorno la stessa cosa di un’assurda guerra? Non si gioca, forse, sul patibolo, con le vite degli uomini? Chi può arrogarsi il diritto di decidere chi vive e chi muore?
Il grande autore nei suoi romanzi sostiene che forse il dolore principale, il più forte, non è quello delle ferite; è invece il sapere con “certezza che, ecco, tra un’ora, poi tra dieci minuti, poi tra mezzo minuto, poi ora, subito, l’anima volerà via dal corpo, e non sarai più un uomo.” “Vivere, vivere, vivere! Vivere in qualunque modo, ma vivere!”. Parole divine, che colpiscono se messe in relazione con quanto sta avvenendo in queste ore in Ucraina, dove uomini, donne e bambini sono costretti a fuggire e ad abbandonare le proprie case in nome di un conflitto che non hanno provocato. Vittime di una guerra nata per dividere e distruggere, uccidere e rovinare. Ma in nome di cosa poi? Della…pace? Ma è mai esistita, veramente, la pace? Non è forse vero che l’uomo non nasce come essere sociale, ma solo come un’unità e che è stato costretto, dalle leggi, ad agire ed a tener conto del bene collettivo? Ecco, io parlerei piuttosto di ordine anziché di pace. Le guerre spesso, infatti, sono dissidi tra due o più uomini, e non tra nazioni. E qual è l’unica cosa che ci unisce veramente, che ci sprona alla solidarietà e alla vicinanza, che ci fa sentire parte di un unico destino, se non la cultura?
Quante volte ci è capitato di leggere un libro, magari la storia di un uomo e rimanerne talmente colpiti perché tra quelle stesse pagine si è intravista l’ombra della nostra vita, dei nostri sentimenti, dei dolori o delle gioie che abbiamo provato? La cultura sono le parole di un attore a teatro che recita la nostra parte. La nostra storia è il suono di un’orchestra che ci ammalia e che ci riporta alla memoria vecchie sensazioni, è un quadro che ritrae la nostra confusione e sono i versi di un poema o di una poesia a noi cara.
Dalla cultura non possiamo che imparare e dunque evolverci a favore di un mondo migliore, imparando dalla storia e dalle parole dei grandi del passato. Per questo e molto altro dovremmo leggere di più, studiare e appassionarci ancora di più a tutto ciò che è il nostro passato e la storia stessa in periodo di guerra, perché ogni conflitto è interruzione della vita e del tempo e solo la cultura può darci coraggio e speranza.
A cura di Diletta Zaccagni