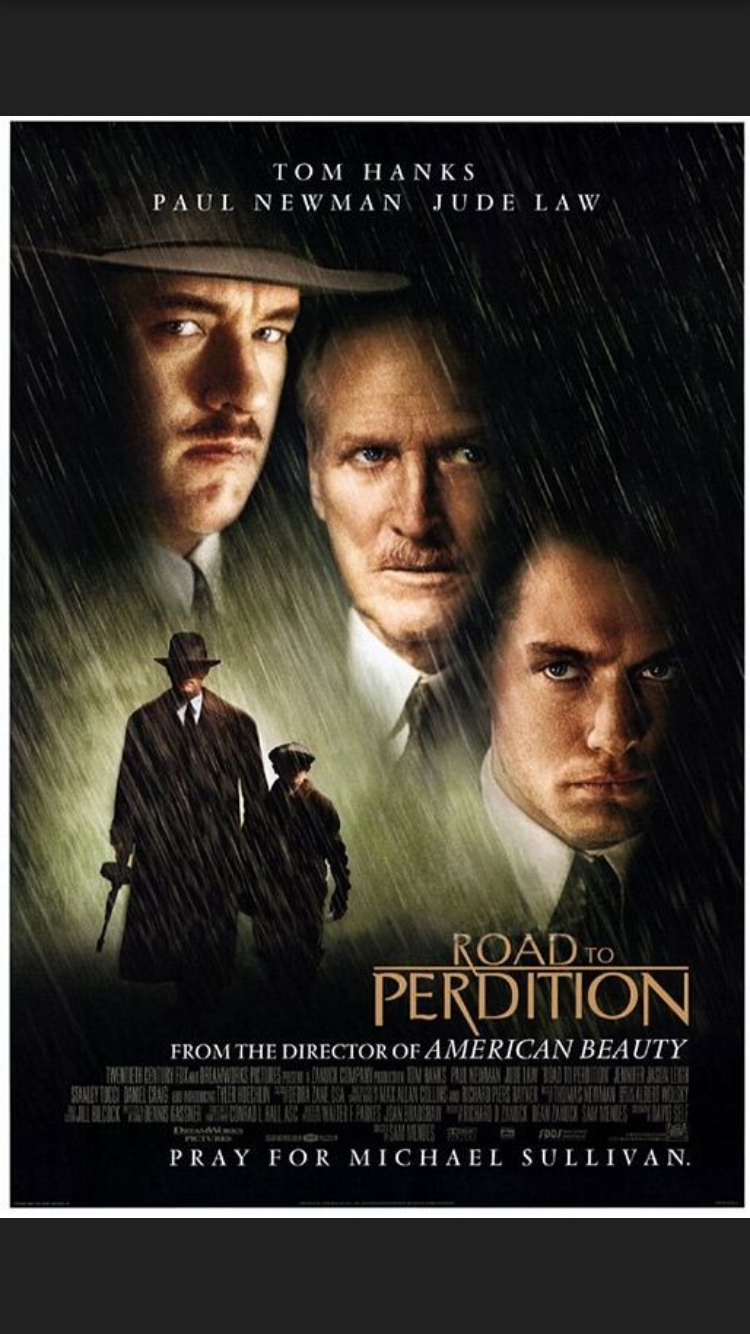In un’intervista, Bernardo Bertolucci aveva detto di essere pessimista sulle sorti del cinema italiano, almeno finché, nel 2008, non uscirono due film: Gomorra e Il Divo. Ed è proprio sul Divo che mi vorrei soffermare. Riguardandolo di recente, infatti, dopo molto tempo dalla prima visione, vi ho trovato una grandezza artistica che lo rende, a mio parere, uno dei film più importanti per il cinema italiano del nuovo millennio. Il Divo è, forse, il culmine di un percorso artistico, quello di Sorrentino, iniziato da uno straordinario – in senso etimologico – stadio embrionale: quel capolavoro dell’Uomo in più. Tutta l’esperienza accumulata con gli anni si è inevitabilmente riversata nel Divo, concorrendo alla realizzazione di un’opera complessa e profondissima. Nel Divo, Sorrentino ripercorre i turbolenti anni ’90 dal punto di vista dell’uomo più potente della Prima repubblica: Giulio Andreotti, appunto, il Divo. Andreotti ci viene mostrato per quel che è: un uomo assetato di potere, e, quindi, intrinsecamente solo. Il potere è questo: solitudine, sosterrebbe Elias Canetti. Il potente ricerca la solitudine per evitare che la sua autorità gli venga sottratta dal prossimo. Nel film, viene ripetuto più volte tale concetto. Lo stesso Andreotti – interpretato da un magistrale Servillo – afferma che, nella sua vita, ha conosciuto, visto il suo ruolo, più o meno trecentomila persone, ma che questo non faccia di lui un uomo meno solo. La tragicità di una vita passata esclusivamente dietro alla politica è enfatizzata da una fotografia cupa, fatta di interni poco illuminati, barocchi, polverosi. Andreotti esce di casa di notte, prega in una chiesa fredda e nella penombra. La Camera dei deputati sembra immersa nell’oscurità, rischiarata solo da bagliori rossi e arancioni. Quelle poche volte che c’è un cielo sereno, la luce è fioca, talvolta entra incerta nelle stanze. Solo in un caso, la luce illumina con forza gli elementi che incontra, quasi accecando. È il momento in cui Andreotti bacia Totò Riina. È un evento che si allontana dal resto del film: non c’è più spazio, qui, per le ombre del sotterfugio politico, per le stanze poco illuminate di una coscienza pesante, quale è quella di Andreotti. La luce della verità ha il compito di rischiarare ciò che è stato, che qualcuno ha visto, che molti negano.
Nella sua conformazione fisica, Andreotti, già dalle prime scene, appare come un essere sgradevole. Quando pedala, all’inizio del film, sulla cyclette, ha un corpo molle, come quello di una rana. A me ha ricordato, in particolare, la Metamorfosi di Kafka: un uomo si è tramutato in qualcos’altro, e questa nuova condizione comporta, inevitabilmente, dei drastici cambiamenti fisiologici. Andreotti, infatti, per tutto il film, beve solo aspirine disciolte in acqua, per lenire i lancinanti mal di testa che lo colpiscono costantemente. La gobba gli pesa sulle spalle, ha il passo affrettato, quasi clownesco. Tra Andreotti e gli altri c’è sempre un notevole distacco: è quello, come abbiamo già detto, del potere, che tramuta l’uomo ‘kafkianamente’. Surreali, poi, sono gli ambienti in cui si muove Andreotti: da edifici del potere neoclassici che ricordano una certa metafisica – de Chirico in particolare –, dove si possono addirittura incontrare dei gatti, fino agli interni di una casa borghese, che, però, riserva tratti grotteschi. Ad esempio, in una scena Andreotti recita furiosamente, palesando tutta la sua animalità, un monologo sul potere direttamente da una stanza di casa sua, illuminato da quei faretti che si possono trovare nei teatri. Scena bellissima, peculiare per la sua costruzione, che introduce, e in parte elabora, uno dei temi cardine del film, assieme a quello del potere: la religione. La religione che si fonde col potere nel momento in cui Andreotti applica l’etica di Dio alla politica degli uomini: senza il male non può esserci il bene. Una visione che, ad esempio, Saramago affronta in maniera sublime nel suo Vangelo secondo Gesù Cristo. Il Dio di Saramago, infatti, dice esplicitamente che il Diavolo deve esistere, e che la sua esistenza è fondamentale, perché senza Diavolo non esisterebbe lo stesso Dio. Così anche Andreotti afferma la necessità della violenza contro quei pochi amanti della verità, per garantire il benessere collettivo. “La verità è la fine del mondo”, grida quasi disperato Andreotti, concludendo con “bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa, e lo so anch’io”.
Il Divo non si può definire un film biopic, né tantomeno un affresco storico di ampio respiro, come può essere Novecento del già citato Bertolucci. Il Divo è un film estremamente intimo, che non umanizza Andreotti, tutt’altro, che mette a nudo gli aspetti più tragici e terribili di un uomo ossessionato dal potere, tormentato dai sensi di colpa – su tutti, la consapevolezza di aver lasciato morire Aldo Moro –, un uomo che è sceso a patti con la mafia, un uomo estremamente solo e lontano dai suoi simili. Eppure, la tentazione del potere ci è vicina più di quanto possiamo pensare, e la metamorfosi in uomini spietati non sembra troppo improbabile. Tracciando il profilo di Giulio Andreotti, Sorrentino parla di tutti noi, delle nostre inquietudini, dei nostri errori, delle nostre debolezze. E lo fa con una regia magistrale, che alterna toni incalzanti e pop a quelli di un cinema più europeo e d’autore. Un intelligente connubio che, assieme a una bellissima fotografia, lo rende tecnicamente eccellente. E poi la sceneggiatura, le interpretazioni, la trattazione dei temi. Tutto ciò è la grandezza del Divo.
A cura di Federico Spagna